Il nuovo quarant’anni dopo la fine del nuovo
11 settembre 2023

Il testo che segue è stato letto al MAD (Murate Art District) di Firenze il 10 settembre 2023, in occasione del Convegno “La musica contemporanea tra presente e futuro”, organizzato dalla SIMC per il suo centenario.
Mi si chiede di esprimere un parere sullo stato presente e sulle prospettive future della musica contemporanea. Che cosa penso, che cosa sento, che cosa vedo. In dieci minuti. Ci provo.
A me pare che la musica contemporanea goda buona salute. Guardiamoci intorno: ci sono molti compositori che la scrivono e molti interpreti che la eseguono; e quindi anche, evidentemente, degli spazi che la accolgono e diffondono. La qualità della scrittura e delle esecuzioni è mediamente buona, non di rado ottima. Ci sono molti giovani preparati, attivi, determinati e agguerriti che si dedicano con passione a questo genere di musica. Escono ancora e perlopiù dai conservatori: si tratta infatti di un genere musicale che si identifica innanzitutto come una tradizione, che sia quella dell’avanguardia, della transavanguardia, del postmoderno o della musica classica tout court (classica, colta, seria, scritta, d’arte, etc.).
La ‘musica contemporanea’ c’è, c’è ancora. È viva e vegeta. Il problema non è la sua esistenza, né il suo invecchiamento o esaurimento. Il problema è la sua ricezione. Ma attenzione: non la sua ‘visibilità’, come si direbbe superficialmente e sbrigativamente, oggi. La sua ricezione, che è ben altra cosa. La visibilità è categoria che appartiene al marketing, la ricezione appartiene invece all’arte. La ricezione è l’esperienza dell’arte. Il suo ‘inveramento’, come si sarebbe detto un tempo e in certi ambienti. La ricezione non è l’ascolto dell’opera, ma la sua metabolizzazione: la ricezione è il ri-ascolto, dell’opera. Per essere compresa un’opera va ascoltata e soprattutto riascoltata, non una ma numerose volte. Perché l’opera d’arte non è mai una cosa semplice, e perciò richiede sempre un momento di riflessione che accompagni e segua il suo ascolto.
Ecco: noi sembriamo non poter disporre più di questo momento cruciale. Non disponiamo più, in generale, di tempo. L’età media si è innalzata, disponiamo di tutto e immediatamente eppure, paradossalmente, non disponiamo più di tempo. Abbiamo scaricato moltissima musica nel nostro computer, ma non abbiamo il tempo di ascoltarla. È che le cose sono cambiate così tanto e così velocemente, negli ultimi, diciamo, trent’anni, che è come se il tempo si fosse fermato, fosse sparito. Viviamo, come acutamente profetizzò il filosofo Jean Baudrillard proprio una trentina d’anni fa in un suo famoso saggio, nell’illusione della fine e nello sciopero degli eventi.
Mia figlia diciassettenne giura di riconoscere se un brano trap è stato scritto ieri o cinque anni fa: io, per me, non sarei assolutamente in grado di dire se un pezzo di musica contemporanea è stato scritto ieri, cinque anni fa, nel 1997 o nel 2008. A meno che non sia un fattore esterno a identificarla, riconosco la storicità degli stili e dei linguaggi musicali fino, diciamo, alla metà degli anni Novanta, poi più nulla, come se il tempo avesse impresso una curvatura alla storia e l’avesse costretta in una vorticosa girandola in cui ritornano continuamente le stesse cose. Un carosello di neo-neo-neo e di post-post-post, ma senza l’ombra di novità. E infatti mia figlia e i suoi amici quando vanno a ballare non si scompongono minimamente se fra due pezzi techno viene messa Stayin’ alive, mentre ai nostri tempi, se il dj avesse messo Maramao perché sei morto fra due pezzi disco sarebbe stato lapidato.
Nondimeno, dicevo, in questi trent’anni è cambiato tutto. Mentre sembra non essere cambiato niente, è in realtà cambiato tutto. Nel ’90 presi un treno e andai a Zurigo per comprare delle partiture da Jecklin; ci voleva meno tempo che farle arrivare qui a Firenze da Ceccherini. Ora sono tutte su YouTube. All’epoca, procurarsi gli opera omnia di un qualsiasi autore di media prolificità richiedeva mesi o anche anni; oggi in poche ore si compila una playlist. E così via. Ma allora perché, nonostante questa facilità nel reperire le cose, sembriamo poi non avere il tempo di recepirle? Forse perché, di pari passo con l’età media, si è innalzato anche il rumore di fondo della vita. Si è incrementata vertiginosamente la quantità di informazione: vi è così un fortissimo elemento di disturbo che si frappone sempre più tra noi e le cose. Insomma, i nostri giovani musicisti godono, sì, di ottima salute, ma è come se avessero preso un treno per Darmstadt e si fossero poi ritrovati a Rimini di Ferragosto.
Ogni zona, per quanto piccola e circoscritta, è occupata da qualcuno. Ogni frase, per quanto intensa o sensata, viene pronunciata in mezzo a mille altre, dispersa in un oceano di bocche e di orecchie. Sembrano banalità, e in effetti quante volte si son sentite dire, queste cose? Ma è esattamente ciò che è accaduto, ciò in mezzo a cui ci troviamo. Prima, come diceva Nanni Moretti in una celebre battuta del suo film Bianca, le cose erano più nette, si distinguevano meglio. Era insomma più facile orientarsi, avere punti fissi di riferimento. E non è, si badi, solo una questione di vecchio e nuovo, di conflitto o di pacifica convivenza tra i due. I linguaggi hanno fatto pace già da un bel po’, mi pare, e sono sempre esistite fasi di stagnazione, di riflusso o di sospensione: si chiama ‘maniera’ e anch’essa ha prodotto capolavori.
Torniamo dunque alla questione della ricezione. Non riguarda soltanto la musica contemporanea, evidentemente: la letteratura, e soprattutto il cinema, mi sembra siano messi un po’ meglio; ma le arti plastiche per esempio, per quanto diverse, mi pare invece condividano con la musica colta questa condizione di difficoltà ricettiva, di dispersione e disorientamento. Il pop, d’alta parte, ne risente molto meno, ma è aiutato dalla sua forza d’impatto e dalla sua naturale tendenza al consumo immediato. La musica colta richiede invece pazienza, attenzione e cura. È dunque più una questione di cura che di tempo? Può darsi, ma non si può dare l’una senza l’altro. Per quanto la musica colta costituisca una nicchia, oggi vi sono centinaia di compositori, ciascuno con un proprio profilo social e con tutta la propria produzione a disposizione dell’ascoltatore. Sono migliaia di opere a portata di clic. Come operare una selezione? Chi ci guida in questo labirinto? Esiste un testo assimilabile a ciò che costituì, per la nostra generazione, Fase seconda? Mi pare di no. Sarebbe, del resto, impresa titanica. E non è un caso se oggi nei titoli dei libri si faccia riferimento a oceani di suono o a residui di rumore.
È la realtà in cui ci troviamo immersi. Certo, la si può interpretare come un segno inequivocabile di ricchezza, vitalità e libertà di scelta: ma non ci si può sorprendere se vi si manifesta contemporaneamente un senso di sbigottimento e di noia. Potremmo allora, un po’ prosaicamente, affidarci alle statistiche: googlare “i dieci compositori viventi più eseguiti al mondo” (ricordo di aver letto su internet, non molto tempo fa, un articolo con un titolo simile), ascoltare – magari fino in fondo! – alcune loro opere e farci un’idea di cosa sta succedendo e di dove stiamo andando (da dove veniamo invece lo sappiamo benissimo). Ma, anche qui: non saremmo certo noi, cittadini delle nicchie da quando avevamo tre anni, a lasciarci sedurre dal mainstream e dalle sue logiche o dal numero di visualizzazioni di un video di YouTube. Sappiamo fin troppo bene che spesso le cose più preziose e singolari sono quelle più nascoste e apparentemente più fragili – Webern docet, ancora, e io sono pronto a scommettere su Wolff.
Ma forse tutto questo non è che il delirio di chi sta entrando lentamente in una fase di demenza senile. E così come è sempre stato, così come abbiamo avuto dieci classici, dieci romantici, dieci moderni e dieci contemporanei, un giorno avremo anche i dieci non-si-sa-cosa di oggi, magari – perché no? – metà dei quali fighissimi rappresentanti dell’Intelligenza Artificiale. Alla fine siamo, comprensibilmente, tutti solo un po’ stanchi, e non sarebbe poi così male riposarsi un po’, ricondurre la vertigine a un innocuo gioco d’immagini.
Cosa resta, dunque? Più nulla, davvero? Solo la vertigine è in grado di dare un senso alla vita artistica? Non anche e non più quell’innocuo gioco d’immagini di cui parlava il buon vecchio Kant? Può sopravvivere l’arte senza la sua ricezione? È questa l’ultima domanda, la più fondamentale e insieme la più incalzante e urgente. Vorrei dire di sì, anzi lo affermo convintamente: quello che resta è il senso di necessità, l’impulso irrefrenabile a creare: cieco, folle, insensato, coatto. Quello di chi continua a parlare da solo o ai muri. Quello dei fiori che sfondano l’asfalto anche se non curati da nessuno; quello dei cespi di ginestra contenti dei deserti e sparsi sull’arida schiena dello sterminator Vesevo. D’altronde, Donatoni una volta rispose giustamente a Clementi che “il funerale si fa una volta sola”. Ma Clementi fu equivocato: quando parlava della “fine della musica” non intendeva dire che la musica sarebbe finita, ma più semplicemente che, siccome tutto avrà una fine, avrà una fine anche la musica.
Grazie.
Livorno, 5 settembre 2023
Testimonianza su Giancarlo Cardini
13 marzo 2023
Quello che segue è il mio contributo alla giornata dedicata a Giancarlo Cardini, organizzata dal GAMO e svoltasi presso il conservatorio “L. Cherubini” di Firenze il 12 marzo 2023
Preceduto dalla sua fama, conobbi personalmente Giancarlo Cardini il primo settembre del 1990, lo stesso giorno in cui conobbi anche Aldo Clementi. Mi ero infatti iscritto al Corso di Perfezionamento in Composizione che il GAMO all’epoca teneva annualmente e che quell’anno e il successivo fu tenuto da Clementi. Mi era sembrato subito che fosse una persona schiva, timida, introversa e riservata, ma quando vide che la mia borsa era piena di partiture di Morton Feldman (ero appena tornato da Zurigo, dove ne avevo acquistate una ventina) si sbottonò immediatamente e mi chiese di dargli del tu. “Ma sono tutte di Feldman?”, chiese con espressione stupita e con la sua voce inconfondibile, che subito imparai ad imitare; “Sì, è il mio compositore preferito”, risposi – “Allora diamoci del tu”, replicò. Da quel momento diventammo amici e fino a un paio d’anni fa, quindi per circa trent’anni, ci siamo visti una media di tre o quattro volte l’anno, cioè un centinaio di volte.
“Ci siamo visti”, ho scritto; più precisamente, andavo a trovarlo a casa sua. Un sabato, o una domenica, prendevo la macchina e da Livorno andavo a Pomino, dove restavo per pranzo e fino a sera. Andavo insomma, come si diceva un tempo, “a trovare un amico”, un’abitudine che oggi forse si è un po’ persa e che invece costituisce uno degli aspetti più belli e importanti della vita umana. Tranne rari casi, infatti, non c’era mai uno scopo diverso dal semplice vedersi per passare una giornata a conversare, ascoltare musica, leggere, analizzare insieme libri e partiture, attingendo alla sua sterminata, ricchissima biblioteca.
Non erano insomma incontri di lavoro, non si discuteva di progetti o di cose concrete da fare, ma solo della nostra comune passione, la musica. Quello che ho preso e imparato, quello che mi hanno dato quegli incontri ha avuto per me un valore inestimabile e ha influenzato profondamente e in larga parte la mia vita non solo di musicista. Ciò che mi colpiva, che amavo di più in Giancarlo non erano infatti le sue competenze di musicista, il suo rigore e la sua acutissima intelligenza di interprete magistrale e di compositore, ma la sua attitudine umana complessiva, il suo amore per le cose e soprattutto la sua unica, straordinaria sensibilità. Non ho mai conosciuto una persona più attenta di lui alla minima sfumatura di senso, al minimo dettaglio di vita quotidiana o al più insignificante evento. “Un cassetto si trova aperto un po’ meno di metà”, recita uno dei ‘frammenti di contemplativo quotidiano’ contenuti nel suo libro Bolle di sapone: ecco, Giancarlo era uno capace di stare a pensare per un’ora di seguito a un cassetto “aperto un po’ meno di metà”, di contemplare tutto il suo mistero, di sentire tutta la sua fragile bellezza e poesia. E naturalmente questo mistero, questa poesia era anche capace di rifletterla, di evocarla, di esprimerla nelle sue composizioni. Da Una notte d’inverno (la mia preferita) a Lento trascolorare dal verde al rosso in un tralcio di foglie autunnali, da Ultimi fiori verso sera a Una lenta malia, da Campagna di sera, il lume di una casa in lontananza al più recente Via del Fico, Firenze. Una piccola strada disadorna, silenziosa, quasi immota, arida e bella: lì tutto è incanto, fascinazione, rituale, mistero, bellezza. Un suono tendenzialmente statico (ma vibrante!), un lento riverberare di accordi e di arabeschi, di silenzi e di poche figure ripetute. Una musica improntata alla contemplazione, sì, ma piuttosto alla prossimità che alla distanza: una contemplazione attiva, non passiva, tattile, che tocca e carezza gli oggetti che evoca. Se nella musica del già citato Feldman, forse il compositore stilisticamente a lui più vicino, la contemplazione sonora è sempre improntata a un astrattismo di derivazione pittorica, nelle opere di Giancarlo vi è invece una forte componente che definirei erotica e naturalistica. “La musica deve far godere. Tutto il resto è secondario. L’unica cosa veramente importante nell’esperienza musicale è dunque la fascinazione, e non considerazioni estrinseche riguardanti la filosofia, l’etica, la spiritualità, la politica”: in questo suo aforisma è racchiusa tutta la sua estetica musicale.
Da giovane aveva frequentato assiduamente il cenacolo che si costituì intorno a Roberto Lupi, figura importante nella vita musicale fiorentina degli anni Cinquanta e Sessanta, e si era quindi interessato all’Antroposofia di Rudolf Steiner e più in generale allo spiritualismo fin de siècle (sui suoi scaffali ricordo numerosi volumi dedicati alla magia e perfino, tomo imponente, l’Iside svelata di Madame Blavatsky), ma poi se ne allontanò per il carattere un po’ troppo settario e intransigente che animava quell’ambiente, laddove Giancarlo aveva un’anima profondamente laica, libertina e libertaria. Le tracce più profonde le lasciarono semmai lo Zen e le filosofie orientali, tracce tangibili e trasversali a molte sue composizioni, dalla Neo-haiku suite del 1979 ai Rituals for the Ryoanji Garden del 2012.
Infine, segno forse ancora più tangibile della sua anima libertaria e indipendente, mi piace ricordare qui l’amore viscerale che nutriva per la letteratura pianistica minore e per la musica leggera, cui ha dedicato una parte cospicua del suo catalogo, che conta numerose trascrizioni da Bindi, Paoli, Tenco, Modugno, D’Anzi, Jobim, Rodgers. Delle canzoni pop Giancarlo amava soprattutto la fragilità e l’immediatezza, l’ingenuità e la sensualità. Anche quando le riveste di sonorità pianistiche sontuose o brillanti, si percepisce sempre il gesto più morbido e carezzevole, il rapimento estatico che queste canzoni esercitavano su di lui.
Negli ultimi anni aveva esteso i suoi interessi alla storia, alla politica e all’antropologia e leggeva moltissimo. Dall’inizio dell’autunno e fino a tutto l’inverno, ogni giorno feriale si recava di buon mattino alla Biblioteca delle Oblate dove si tratteneva fino a sera a leggere e studiare.
La sua scomparsa ha rappresentato una perdita irreparabile per il mondo della musica contemporanea e ha lasciato un vuoto enorme e incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. L’ultima volta l’ho visto il 27 febbraio dell’anno scorso, una domenica, a Camaiore, dove era ospite della nipote. Non so se mi ha riconosciuto, la malattia era già in una fase avanzata.
Mi ritrovo spesso a pensarlo e lo vedo ancora e sempre intento a fissare qualcosa, come perso a seguire un pensiero o chissà che; non era certo facile intuirlo. Aveva anche, come tutti i grandi, un’ironia finissima e sfuggente. Uno dei suoi primi e meno conosciuti pezzi, La durezza delle pietre, per pianoforte preparato e amplificato, trentanove assi di legno, tam-tam e nastro magnetico, venne registrato ed incluso nel primo vinile interamente dedicato alle sue composizioni, che uscì negli anni Ottanta allegato a un numero di 1985 La Musica, la rivista di musica contemporanea diretta da Daniele Lombardi e Bruno Nicolai. Non fu soddisfatto della registrazione, che a suo dire aveva alterato seriamente il senso del pezzo, e finì per ripudiarlo e per toglierlo dal catalogo delle opere. Un giorno mi mostrò la partitura di questo pezzo: centottanta pagine fitte, piene di cluster pianistici collocati sulla linea del tempo con precisione maniacale. “Un pezzo piuttosto inconsueto rispetto agli altri”, gli dissi. Uno dei pochissimi infatti, forse l’unico, in cui aveva adottato uno dei metodi compositivi aleatori di John Cage, quello che prevede l’annerimento delle imperfezioni presenti in un foglio di carta, usato dal compositore americano per la serie Music for piano negli anni Cinquanta. In questo caso però Giancarlo, invece delle imperfezioni della carta, annerì le imperfezioni di un muro. C’era infatti un lungo muro che aveva attirato la sua attenzione in una via di Settignano, e lo aveva mappato su carta: ogni cluster rappresentava uno dei numerosi ciuffi d’erba sporgenti dal muro. Per mapparlo tutto gli ci vollero ovviamente diversi giorni (di qui le centottanta pagine): immagino cosa debbano aver pensato i passanti che lo vedevano lì in piedi a fissare questi ciuffi d’erba e a trascriverli sulla carta, e sorrido.
Desidero qui ringraziare dal profondo del cuore Giancarlo per avermi insegnato a guardare con altri occhi e ad ascoltare con altre orecchie la realtà, per avermi dischiuso nuovi e sconosciuti orizzonti di vita e di poesia, per aver illuminato la mia strada con una luce soffusa ma inestinguibile, che continua a irradiare i suoi bagliori e a sostenere il mio cammino incerto. La sua solitudine, la sua unicità è stata e continua a essere per me un punto fermo nell’abisso di oscurità in cui sembriamo tutti lentamente ma inesorabilmente sprofondare.
Il mistero della sigla di “Che tempo fa”
3 settembre 2022
Tutto prese spunto, una ventina d’anni fa, da un ritaglio del RadiocorriereTV (n. 23 del 4-10 giugno 1967, p. 55) che mio nonno aveva incollato in uno dei diciotto quaderni manoscritti che costituivano il catalogo dei suoi dischi. Il ritaglio riporta le fonti di alcune delle più note sigle musicali utilizzate all’epoca dalla Rai, tra le quali figura, appunto, quella delle Previsioni del Tempo, che riporta la seguente fonte: Zalvidar-Robuschi, Vacanze in Argentina, Disco Red Record 25002.
Non sapendo chi si celasse sotto il presunto pseudonimo ‘Zalvidar’ (seppi poi che si trattava di Gian Stellari, direttore d’orchestra e compositore di musica leggera), cercai notizie sul secondo, Guido Robuschi, e riuscii a rintracciare il suo numero di telefono sulle Pagine Bianche. Lo chiamai e fu molto gentile e disponibile, confermandomi di essere l’autore di quella sigla e raccontandomi degli aneddoti al riguardo. Andai quindi a cercare su Internet quel disco indicato nell’elenco del Radiocorriere, ma di un disco siglato “Red Record 25002” non trovai traccia; ne trovai un altro in tutto simile tranne che, stranamente, nel numero di catalogo (ce ne sono due, quindi? O – più probabile, ritengo – sull’elenco è riportato un numero sbagliato?). Quando mi arrivò e lo ascoltai, però, non trovai alcuna traccia di quella sigla storica, né nella versione originale né in una sua presunta trascrizione o arrangiamento. Allora pensai (e penso tuttora) che quel titolo “Previsioni del Tempo” indicato nel Radiocorriere si riferisse non al programma della sera (quello con il barometro nei titoli di testa), ma a quello della tarda mattina (ve lo ricordate? con il disegno di un sole sorridente in sigla), di cui non ricordo bene la musica che lo accompagnava (non ricordo cioè se era la stessa di Che tempo fa o se era diversa) ma ricordo, seppur vagamente, che durante la lettura delle temperature delle capitali europee (mi è rimasta particolarmente impressa quella di Istanbul, perché spesso era “non pervenuta”) c’era una musica di sottofondo, che potrebbe appunto essere quella a cui si riferisce il Radiocorriere (e quella del disco, ma su questo ho forti dubbi, perché, per quanto vagamente, ricordo una musica lounge, di ‘atmosfera’ insomma, con in primo piano un vibrafono, mentre la musica del disco è tutta un po’ simil-andina, caraibica o brasileira e molto ‘spavalda’, non certo da sottofondo). Il mistero è dunque tuttora irrisolto. In un forum del 2008, ancora visibile (http://www.tv-pedia.com/zapzaptv/viewtopic.php?f=3&t=824) si fa poi riferimento a un brano, tra diversi omonimi, depositato alla Siae e intitolato “Che tempo fa”, attribuito a un certo Adelmo Amadori (musicista però di cui non ho trovato alcuna traccia). Forse dando un’occhiata a questo brano si potrebbe decidere se la musica della sigla è dunque di Guido Robuschi o di Adelmo Amadori, ma rimarrebbe il mistero di come questo Vacanze in Argentina (film di Guido Leoni del 1960 con Walter Chiari) sia legato al programma Rai.
(Ah, ma quanto mi piacciono queste storie… ne ho collezionate tante, nella mia vita).

Ricordo di Giancarlo Cardini
26 luglio 2022

Non ho voglia, né mi sembra il caso, qui, di (anche solo provare a) raccontare tutto quello che Giancarlo Cardini è stato e ha rappresentato per me, per me come musicista ma innanzitutto come persona. Un faro, una guida, un punto di riferimento assoluto, ma soprattutto un grande amico che ho frequentato assiduamente per più di trent’anni, da quando, nell’ormai lontano 1990, mi presentai alla sede staccata del Conservatorio “Cherubini” di Firenze per seguire i Corsi di Perfezionamento in Composizione tenuti da Aldo Clementi e organizzati dal GAMO (Gruppo Aperto Musica Oggi), l’associazione culturale fiorentina da lui fondata e presieduta per molti anni, che tanto ha fatto e continua a fare per la valorizzazione e la divulgazione della musica contemporanea. Ero appena tornato da Zurigo, ricordo, dove avevo acquistato da Jecklin una trentina di partiture di Morton Feldman e lui, vedendole, mi chiese: “Ma sono tutte di Feldman?”. “Sì”. “Diamoci del tu, allora”. Questo buffo aneddoto segnò l’inizio della nostra grande e lunga amicizia, alla quale devo moltissimo. Ma per chi invece non lo ha conosciuto – soprattutto i giovani – vorrei provare a dire, anche se di necessità brevemente, quello che Cardini è stato in generale per la storia della musica italiana e non solo.
Giancarlo Cardini è conosciuto soprattutto per essere stato un grande interprete di molti ormai ‘classici’ della musica d’avanguardia italiana e internazionale, in primo luogo dei compositori a lui geograficamente più vicini (su tutti Bussotti e Chiari, ma anche Luporini, de Angelis, Zosi, Lombardi, Pezzati e molti altri dell’area fiorentina e toscana) e di quelli dell’ambiente milanese, assiduamente frequentato negli anni Settanta e Ottanta (Castaldi in particolare, ma anche l’ambiente della Cramps di Gianni Sassi, al quale lo legavano una solida amicizia e una stima reciproca e per il quale incise molti dischi – tra cui la straordinaria Natura morta di Walter Marchetti e l’opera omnia di Satie, che attende ancora di essere pubblicata). Storica fu la sua partecipazione al Concerto per Demetrio Stratos, tenutosi il 14 giugno 1979 all’Arena Civica, al quale contribuì con Novelletta di Bussotti e col celeberrimo Cardini di Castaldi, solfeggio parlato a lui dedicato dal compositore milanese e che declamò con grande spirito di abnegazione davanti a sessantamila giovani.
Una grande amicizia lo legava anche ai compositori della New York School, in particolare a Feldman e a Cage, dei quali interpretò magistralmente le più importanti pagine pianistiche (il 21 giugno 1992 a Firenze organizzò col GAMO un importante concerto monografico dedicato a Cage, con la presenza dello stesso Cage, appena due mesi prima della scomparsa del compositore americano).
Le sue interpretazioni erano caratterizzate da un grande rigore esegetico, da una profonda musicalità (tocco e fraseggio unici) e da una tecnica impeccabile, ma soprattutto da una fortissima empatia verso l’universo poetico del compositore, che egli sapeva restituire agli ascoltatori con grande trasporto e passione. Sotto quest’ultimo aspetto può essere considerato, insieme a pochi altri pianisti (Cardew e Tudor sono i primi esempi che mi sovvengono) come un caso emblematico della vexata quaestio relativa alla musica indeterminata (o aleatoria che dir si voglia). ‘Emblematico’ nel senso che nel suo caso è difficile più che in altri stabilire quanto c’è del compositore e quanto dell’interprete nell’esecuzione di brani ‘aperti’, come ad esempio nei Gesti sul piano (1963) di Chiari e nella già citata Novelletta (1973) di Bussotti (suo cavallo di battaglia per lunghi anni e brano controverso, perché in apparenza palesemente debitore di Body piano, un brano improvvisato che Cardini suonò spesso a partire dal 1972 e che non è stato mai trascritto su carta): in casi come questi, insomma, l’interprete dovrebbe essere considerato a tutti gli effetti, e in varia misura – tali i termini della quaestio – un co-autore.
Poi, dai primi anni Ottanta, all’assidua attività concertistica che lo aveva portato a esibirsi in tutto il mondo iniziò ad affiancare un’attività compositiva che negli anni si è sempre più infittita, anche se – per il suo carattere schivo e la sua indole solitaria – è purtroppo meno conosciuta, fatta forse eccezione per le trascrizioni pianistiche di canzoni di musica leggera alle quali era molto legato (canzoni di D’Anzi, Modugno, Bindi, Paoli, Tenco, Jobim, Rodgers e altri). La sua produzione, prevalentemente (ma non solo) pianistica, annovera alcuni gioielli di grande respiro e di profonda intensità espressiva: da Una notte d’inverno (1982) a Lento trascolorare dal verde al rosso in un tralcio di foglie autunnali (1982, recentemente reintitolata Foglie d’autunno lentamente trascolorano), entrambe per pianoforte; da Il castello insonne (“Mistero scenico notturno in 29 episodi da eseguirsi tra le due e le quattro di una notte senza luna, per strumenti musicali, oggetti, strumentisti e performers”, come recita il sottotitolo), a O quieta e dolce mattina d’ottobre (1990, su una poesia di Robert Frost, per voce recitante, pianoforte e percussioni); da Ultimi fiori, verso sera per pianoforte a Paesaggio per pianoforte e orchestra (entrambe del 1993); da Campagna, di sera, il lume di una casa in lontananza (1996) per flauto, clarinetto, quartetto d’archi e pianoforte a Paesaggio marino al tramonto con barca e grande nuvola nera (1998) per pianoforte; da Fiore perduto (2001) per fagotto e pianoforte a I prati del Paradiso (2002, otto quadri musicali su poesie di Aldo Palazzeschi, per voce recitante, pianoforte a 4 mani, clarinetto, fagotto, violino, contrabbasso, tam-tam e giocattoli sonori), fino ai più recenti Piano piece for Howard Skempton (2004) e Musica per Davide Mosconi (2010), sempre per pianoforte. Un mondo poetico fatto di sfumature e di contemplazioni statiche (ma sempre vibranti!), che affonda le sue radici in una serie di haiku (o meglio di “frammenti di contemplativo quotidiano”) che il compositore scrisse negli anni e infine raccolse e pubblicò nel 1990 con il titolo Bolle di sapone.
Di Giancarlo rimane anche una cospicua raccolta di saggi, perlopiù incentrati sull’esegesi della letteratura pianistica, che confermano la sua lucidità e capacità di compenetrazione delle opere musicali. Ma soprattutto di lui rimane, per chi, come me, ha avuto la fortuna e la gioia di conoscerlo e frequentarlo personalmente, quell’aura incantata e ironica che sembrava circondarlo perennemente, che a uno sguardo superficiale poteva apparire distrazione o perfino indifferenza e che invece, a uno sguardo più orientato e attento, svelava una rara, enigmatica, unica, profondissima sensibilità.
Teoria estetica
16 agosto 2020

Il maestro e l’allievo. Ancora su Aldo Clementi.
16 aprile 2020
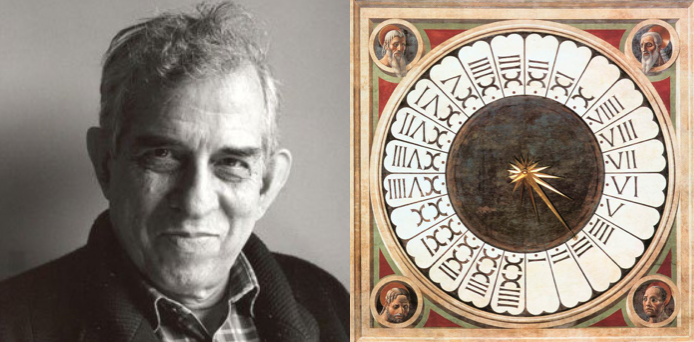
Uno del problemi che ho sempre avuto con la composizione e col suo mondo è il concetto di ‘lavoro compositivo’, un concetto centrale e fondamentale in questa attività creativa, forse molto più centrale che in altre discipline, per varie ragioni che non è il caso qui di approfondire. Il ‘lavoro’, o meglio l’elaborazione del (e sul) materiale compositivo (altro concetto, quello di ‘materiale’, importantissimo nella musica degli ultimi cent’anni) è una prassi talmente scontata che ogni approccio che la ignori o la sottovaluti è visto con sospetto quando non con aperta e irriducibile opposizione. Eppure a me è sempre parso che tanto ‘materiale’ (scale, armonie, rumori, forme, strutture – qualsiasi mezzo espressivo si usi per fare musica) fosse già sufficientemente ‘musicale’ di per sé, avesse poco o nessun bisogno di essere elaborato, strutturato, variato, sviluppato rispetto all’dea originaria, a quella ‘immagine sonora complessiva’ che sta all’origine di ogni pezzo di musica. Credo di aver preso, o meglio rafforzato questa attitudine, dal mio maestro Aldo Clementi, il quale era pur tuttavia un lavoratore instancabile, un vero artigiano del comporre, nel senso che lavorava, scriveva, tutti i santi giorni, un pezzo dopo l’altro, una partitura dopo l’altra, partiture la cui sola stesura comportava spesso un lavoro massacrante e certosino. Ma l’idea centrale di tutta la sua attività compositiva era che, secondo le sue stesse parole, “trovato il codice, il pezzo è finito”, trovata la formula il pezzo va solo steso, ‘scritto’ nel senso più piatto e burocratico del termine. Questi ‘codici’ erano delle regole, delle formule, che servivano per attivare, mettere in moto il meccanismo sonoro, come cioè delle componenti di orologi che segnano tempi di volta in volta diversi (uno “batte le una non appena battute le due”, per dirla suggestivamente con i versi di Emily Dickinson, un altro salta un quarto d’ora ogni mezz’ora, un terzo accelera nelle ore notturne, e così via). “Ma in media quanto ci mette per trovare il codice di un pezzo, maestro?”, chiedevo ingenuamente. “Dipende, a volte è un attimo, a volte ci vogliono diversi giorni”. Un’altra cosa che mi stupiva e affascinava, e che secondo me Clementi aveva preso da Cage, osservandolo lavorare a Fontana Mix allo Studio di Fonologia della Rai di Milano negli anni 1958-59, era l’apparente assurdità dello scrivere a mano centinaia, migliaia di note che erano state generate automaticamente dai codici, l’ostinarsi cioè – un’attitudine quasi Zen, ed è per questo che la associo a Cage – a non voler affidarsi a mezzi tecnologici esterni o ad escogitare metodi stenografici di scrittura abbreviata che avrebbero alleggerito, e di molto, la fatica della scrittura (mi faceva pensare anche a Mondrian, al quale qualcuno suggerì di usare uno spray per far prima a coprire le aree monocrome dei suoi dipinti). Clementi, diversamente dalla quasi totalità dei suoi colleghi, parlava infatti spesso di attività ‘senza scopo’, suggeriva anzi ai propri allievi di composizione di fare degli esercizi ‘senza scopo’ (per esempio suonare delle scale o loro porzioni e frammenti ripetendoli continuamente, oppure contare, mettere in fila dei numeri, etc.). Queste cose, al di là delle questioni estetiche, credo abbiano molto influenzato il mio approccio alla composizione, questo mio trovare ‘musicali’ i materiali sonori nel loro semplice e immediato mostrarsi ed efficaci i più semplici mezzi usati per strutturarli – al di là dei risultati poi effettivamente conseguiti, che non spetta ovviamente a me di giudicare. E hanno soprattutto influenzato la mia vita, dandole un senso. E’ ciò che succede quando si incontrano le persone giuste, i giusti maestri (“quando non si ha un buon padre, bisogna procurarsene uno”, diceva Nietzsche); quelle persone capaci di illuminarti la vita con poche parole e pochi gesti. In questo, credo di essere stato molto fortunato.
Marina, Romina, Bano e Ulay
26 ottobre 2019

Sull’insegnamento
27 luglio 2019

Funziona così. Viene a studiare con te un adolescente come tanti, appassionato della musica di Einaudi e acerbo autore di composizioni nello stile del suo idolo. Te le fa ascoltare con un certo timore ma anche con una punta di orgoglio, com’è ovvio che sia. Le ascolti con la massima attenzione e col massimo rispetto verso il ragazzo. Alla fine fai un sorriso, gli dici ‘bravo’, gli dai dei consigli e dei suggerimenti su come modificare quelli che ti sono sembrati i punti più deboli del brano. Lui presto – siccome è venuto a studiare con te perché vuole studiare con te, perché è interessato a te e ripone fiducia in ciò che puoi insegnargli – ti farà la domanda per lui più difficile: ti chiederà che cosa pensi di Einaudi. E te, siccome non sei uno stronzo né un imbecille, gli dici che apprezzi quello che fa, che è musica semplice e che arriva a molti e questo è un pregio. Lui sarà molto felice di questa tua risposta. Poi gli dici però che secondo te ha un difetto (uno solo): non è molto originale. Lui sarà un po’ dispiaciuto di questo, ma ti ascolterà incuriosito. Sarà curioso di sapere cosa vuoi dire e come andrai avanti col discorso. Allora gli fai sapere che, sì, la musica di Einaudi si ispira alle nuvole del cielo e alle onde del mare, e che tutto questo è molto bello, ma secondo te lo fa modellandosi a uno standard che si trova fuori della sua coscienza, a uno standard che esisteva già prima perché qualcun altro l’aveva già, per così dire, ‘preconfezionato’ per noi. E questo non è molto interessante. E’ più interessante quando un artista cerca nuove strade, soprattutto la ‘propria’ strada, la sua personale. E allora gli fai l’esempio di Feldman e del suo curioso brano Madame Press died last week at ninety, raccontandogli di com’è stato composto, di quali furono le idee che lo ispirarono. E non ti metti a parlargli di teorie, di sistemi o di scale, no, gli racconti semplicemente che un giorno Feldman telefonò alla madre e la prima cosa che questa gli disse fu che la Signora Press era morta la settimana precedente a novant’anni. Ora, siccome la Signora Press era stata la prima insegnante di pianoforte di Feldman e lui le era rimasto molto affezionato, allora Feldman cosa fece, prese la carta pentagrammata e scrisse novanta battute, ciascuna rappresentante un anno della vita della sua insegnante di pianoforte, e in ciascuna battuta ci mise un intervallo di terza maggiore discendente, intervallo che ricorda il suono del cucù o del campanello, come a segnare l’inesorabilità degli anni che passano, ogni volta accompagnato da un accordo diverso, a sottolineare i cambiamenti della vita. A un certo punto, corrispondente all’incirca agli anni durante i quali lui fu suo allievo, il suono si fa un poco grottesco e ironico, prendendo proprio le sembianze di un orologio a cucù, per poi riprendere la sua placida deriva verso la fine, un po’ più velocemente perché, si sa, gli ultimi anni della vita passano più in fretta dei primi. Riempite le novante battute, vi aggiunse, infine, una battuta all’inizio e una alla fine, entrambe con un piccolo arpeggio di celesta, a mo di siparietto: la nascita, appunto, e la morte della Signora Press, Vera Maurina Press, prima insegnante di pianoforte di Morton Feldman.
A quel punto il tuo allievo ti guarderà con uno sguardo che non avevi ancora mai visto nei suoi occhi. Ti chiederà, ovviamente, di fargli ascoltare questo brano, e quando l’avrà ascoltato non sarà più la stessa persona, che gli sia piaciuto oppure no. Si dimenticherà totalmente di Einaudi e comincerà a cercare altre strade, sperando di trovare la sua.
Ecco come si fa a rovesciare le persone come un calzino. Non c’è bisogno di essere dei geni o degli eroi. A volte basta far loro ascoltare o vedere qualcosa di diverso da ciò che hanno sempre visto o che ti fanno sempre vedere. Una roba di mezz’ora, insomma, al massimo di un pomeriggio.
Ecco come funziona.
Premio Parsifal a Flavio Cucchi
6 aprile 2019
![fl_fotka3[1]](https://marcolenzi.files.wordpress.com/2019/04/fl_fotka31.jpg)
Il giorno venerdì 5 aprile 2019 al Palazzo Blu di Pisa è stato conferito il Premio Parsifal a Flavio Cucchi. Avrei dovuto partecipare con una testimonianza orale che poi invece ho mandato scritta. Questo il testo:
Sono molto contento che l’Accademia di Musica ‘Stefano Strata’ abbia deciso di conferire a Flavio Cucchi il Premio Parsifal “Una vita per la musica” e mi dispiace altrettanto di non poter essere fisicamente presente alla premiazione per cause di forza maggiore, per cui affido a queste righe la testimonianza che avrei voluto portare a voce.
***
Non credo spetti a me dire chi sia Flavio Cucchi, che cosa abbia fatto e quale sia la sua posizione nel mondo della chitarra: altri lo hanno fatto e lo faranno meglio di me. Vorrei semplicemente contribuire a questa serata, nei necessari limiti temporali, con un ricordo personale dell’artista, dell’insegnante e dell’amico, cercando di dire qualcosa di ciò che Flavio ha rappresentato per me.
Ho avuto la fortuna, negli anni della mia formazione, di avere come guide, maestri e punti di riferimento tre personalità di spicco della cultura italiana: Aldo Gargani, col quale mi sono laureato in filosofia; Aldo Clementi, che è stato molto importante per i miei studi di composizione; e, appunto, Flavio Cucchi, col quale mi sono diplomato in chitarra all’Istituto ‘Mascagni’ di Livorno, la mia città, nell’ormai lontano 1991.
Conservo un bellissimo ricordo dei sei anni di studio svolti sotto la sua guida: essi costituirono, per me che all’epoca dell’incontro con Flavio ero un diciassettenne di provincia, un notevole salto di qualità sia sotto il profilo tecnico che sotto quello estetico e più generalmente culturale. Nei quattro anni precedenti il mio ingresso in conservatorio avevo studiato serenamente e con passione ma con una certa discontinuità e senza un preciso orientamento: in breve tempo Flavio rivoluzionò la mia tecnica di base, reimpostandola secondo i canoni e i criteri della scuola chitarristica fiorentina di Alvaro Company dalla quale proveniva, e ciò mi consentì di ottenere subito un netto miglioramento nella qualità e nella potenza del suono e una maggior sicurezza nel controllo complessivo dello strumento. Non solo: fin dalle prime lezioni la sua particolare attenzione agli aspetti formali ed espressivi di un brano, fosse anche un piccolo studio, mi rese consapevole del valore artistico e culturale di quanto andavo man mano studiando, allontanando quindi fin da subito lo spettro della settorialità, un vizio e un difetto cui talvolta l’ambiente chitarristico tende a soggiacere. La cosa che mi colpì più di Flavio infatti, al di là della sua evidente competenza specifica e della sua già allora comprovata esperienza di concertista di livello internazionale, fu la sua apertura mentale, i suoi interessi che non si limitavano a quelli circoscritti al mondo chitarristico ma, caso piuttosto raro in un insegnante di conservatorio, si estendevano ad altri ambiti, sia musicali che culturali. Per fare un esempio di tale apertura e disponibilità, posso dire che non solo non gli dava affatto fastidio che io, parallelamente agli studi di chitarra classica, coltivassi la musica rock suonando la chitarra elettrica in una band livornese o studiassi filosofia all’università di Pisa, ma ne era interessato lui stesso, per cui alle lezioni vere e proprie seguivano spesso conversazioni e discussioni di filosofia e di cultura generale su svariati argomenti di attualità: questo suo tratto caratteristico, questa sua curiosità e attenzione verso tutto ciò che è nuovo e che stimola pensieri e riflessioni è un aspetto da cui trassi molto beneficio in quegli anni.
Poi venne Firenze, la città dove Flavio viveva e del cui ambiente musicale, assai stimolante e di ben altra risonanza rispetto a quello livornese, era parte attiva e integrante: per noi – parlo di me e di altri miei condiscepoli, tra i quali voglio ricordare qui Marco Gammanossi, Salvo Marcuccio e Andrea Carli – fu un passo molto importante poter entrare in contatto diretto con quell’ambiente, cosa che avvenne presto grazie soprattutto all’invito, rivoltoci da Flavio, a prender parte dell’Ensemble Ricercare (poi Guitar Symphonietta), un ensemble di ventisei chitarre che si era costituito nella seconda metà degli anni Ottanta e che fu attivo per una decina d’anni circa. Lì avemmo modo di conoscere altri esponenti importanti della scuola chitarristica fiorentina come Paolo Paolini, Alfonso Borghese e Nuccio D’Angelo, e soprattutto avemmo l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Leo Brouwer, che all’epoca veniva spesso a dirigere l’orchestra e col quale incidemmo poi un disco. Grazie alla mediazione di Flavio riuscii così a stabilire rapporti stabili e duraturi col capoluogo toscano, anche al di là della chitarra, rapporti che mi permisero di approfondire la conoscenza della frangia più avanguardistica e sperimentale di quell’ambiente musicale, da Chiari a Bussotti, da Lombardi a Cardini, verso la quale già allora nutrivo una particolare predilezione.
Conclusa l’esperienza con la Guitar Symphonietta abbandonai infatti gradualmente l’attività concertistica per dedicarmi alla composizione e alla ricerca musicologica, ma ciò non fu affatto un trauma né costituì una rottura, lo sentii anzi come una naturale evoluzione della mia personalità musicale, sulla quale Flavio aveva inciso in maniera così profonda e determinante. È nota a tutti, del resto, la passione con la quale, soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, egli si dedicò alla musica d’avanguardia, da quella di Petrassi a quella di Boulez, passando per Henze, Brouwer e Bussotti. Fu da lui che sentii suonare per la prima volta in vita mia quelle musiche per me così nuove e affascinanti (in particolare i brani scritti da Brouwer tra la fine degli anni Sessanta e i primi Settanta, come Canticum, La espiral eterna e Parabola) e fu un grande privilegio poterli studiare e interpretare sotto la sua diretta supervisione: quando poi in seguito cominciai a dedicarmi con maggiore assiduità all’attività compositiva, compresi tutta l’importanza che aveva avuto il lavoro analitico, interpretativo ed esecutivo svolto in classe su quei pezzi.
Non sto, poi e infine, a dire quanta gioia mi abbia procurato l’averlo ascoltato dal vivo in numerose occasioni. Ogni suo concerto era per me un’occasione per godere pienamente della sua straordinaria personalità musicale: il nitore e la precisione del suono, il virtuosismo tecnico, la varietà e la chiarezza del fraseggio, la magia del gioco timbrico e dinamico ne facevano e ne fanno uno dei più grandi chitarristi italiani su scala internazionale.
Aver avuto a Livorno uno come Flavio per trent’anni è stata una grande fortuna, cosa di cui ero già consapevole il giorno stesso dell’esame di ammissione alla nuova cattedra di chitarra dell’Istituto ‘Mascagni’, mentre stavo trepidamente attendendo il mio turno. Qualcuno mi aveva infatti già parlato di lui come di uno “straordinario interprete di Villa-Lobos”, e pochi giorni prima dell’esame lo avevo per caso visto in una trasmissione televisiva in cui stava suonando, per l’appunto, dei pezzi di Villa-Lobos al Palazzetto dello Sport di Milano, accompagnando nientemeno che Carmelo Bene in una lettura dei Canti Orfici di Dino Campana. Rimasi colpito dalle parole che Bene pronunciò su Flavio, definendolo un chitarrista che “buca l’essere”. Mi presentai dunque all’esame di ammissione cercando di ‘bucare’ anch’io, se non proprio l’essere, almeno la sua disponibilità ad accogliermi tra i suoi allievi.
Così fu, e di questo non cesserò mai di essergli profondamente grato.
Giovani e vecchi signorini (di nulla)*
10 giugno 2018

* articolo pubblicato il 4 giugno scorso qui.
Non c’è niente di più naturale per i vecchi del non accorgersi che un tipo di uomo nuovo si sta formando un po’ dappertutto. (Tristan Tzara, lettera aperta a jacques rivière)
L’ultima – ennesima e più recente – querelle des anciens et des modernes sembra si stia svolgendo, qui da noi e nell’ambito della moda e del costume più che dell’arte, sulla scia di alcune canzoni di un ragazzo che fa musica trap[1] e si fa chiamare ‘young signorino’ (un nome d’arte niente male, peraltro, se devo subito dire la mia).
L’argomento è – notoriamente, e da circa duemilacinquecento anni – sempre lo stesso: si manifesta qualcosa di ‘nuovo’ (nel senso più letterale e neutro del termine) al quale da una parte consistente dei consumatori, degli ascoltatori e degli appassionati di musica non viene riconosciuto alcuno statuto di ‘musicalità’. “Questa non è musica” è il topos più abusato, alla cui lapidaria e laconica espressione di solito si aggiunge qualcosa di positivo (anche qui, nel senso più letterale del termine): quella cioè non sarebbe ‘musica’ ma ‘x’, ove ‘x’ sta, di volta in volta e a piacere, per ‘caos’, ‘rumore’, ‘pura merce’, ‘una presa di culo’, ‘cialtroneria’, ‘merda’, etc. etc.
Ora, al di là del sorriso che di per sé dovrebbe suscitare l’infinita riproposizione di una querelle o di una geremiade, di qualsiasi tipo si tratti (ricordo qui, a mo’ d’esempio, il lamento di Severino Boezio sulla decadenza dei tempi che apre il De institutione musica, e che dipinge il genere umano di allora “lascivo e molle, e tutto preso dalle forme sceniche e teatrali” – come non sorridere, leggendolo e pensando all’oggi?)[2]; al di là del sorriso che dovrebbe suscitare lo stesso disco rotto e incantato da duemila anni, dicevo, è sempre interessante osservare come di volta in volta i termini specifici e particolari della questione cambino, assumendo diverse sfumature di significato, sia nelle più alte sfere dell’arte che nella tradizione popolare e nella cultura di massa. Le accuse più frequenti sono quelle per un eccesso di complicazione (sostenute di volta in volta dagli efori di Sparta contro Timoteo di Mileto, da Giovanni XXII contro l’Ars Nova, dai neoromantici contro la musica seriale o dalla scena punk contro la scena prog); quelle, di segno contrario, verso la banalità e l’insulsaggine dei contenuti (pensiamo a cosa pensava Bortolotto di Satie, per esempio, o Berio del primo minimalismo)[3]; ancora, le accuse di non rispettare le regole dell’arte (l’Artusi che rimprovera a Monteverdi di non preparare le dissonanze, i serialisti che rimproverano a Ligeti di abusare delle ottave, i tradizionalisti di ogni risma che stigmatizzano le volgarizzazioni pop della musica classica); quelle di astruseria (Schuppanzigh verso l’ultimo Beethoven, Schumann sul finale dell’op. 35 di Chopin) e di cialtroneria (ancora Berio, riportato da Donatoni, sull’incapacità di Evangelisti di “scrivere un minuetto”, o il disprezzo che qualsiasi musicista capace di strimpellare uno strumento nutre verso i dj)[4]; quella, infine, frequentatissima, di “corrompere i giovani” (da Platone contro il modo misolidio a tutto l’allegro stuolo di preti e di benpensanti contro la ‘musica del diavolo’).
Nel caso specifico, a stare ai commenti di un recente post pubblicato sul mio profilo Facebook, sembra che l’accusa principale verso Young Signorino sia, più semplicemente, quella di essere un ‘coglione’.[5] Infatti, mi si potrebbe subito obiettare che gli esempi fatti sopra sono incongrui e non pertinenti rispetto al caso, perché qui non si tratta del mancato riconoscimento del ‘genio’ ma della semplice e minima, diciamo così, ‘dignità musicale’ della cosa. Eppure, anche qui, che un ‘coglione’ non possa produrre musica è tutto da dimostrare. Credo, per esempio, che un Sid Vicious fosse venti volte più coglione di Signorino, ma ciò non mi pare gli abbia impedito di contribuire a una rivoluzione musicale nell’ambito della storia del Rock. Difficile anche pensare che canzoni come Da da da (1982) dei Trio o perfino Sex and drugs and Rock’n’Roll (1977) di Ian Dury, che ebbero un ampio successo all’epoca, tradissero una mente più brillante o vivace di quella del nostro. Per non parlare di tutta la tradizione avanguardista e sperimentale della poesia sonora, dai gorgheggi di Hugo Ball a quelli di Marinetti o di Schwitters. Insomma, chissà cos’è, davvero, che ci spinge fortemente a pensare che i ‘troiai’ che ascoltano i nostri figli o nipoti siano in qualche modo e misura più troiai di quelli che ascoltavamo noi o i nostri avi. Penso sia un caso particolare della più generale paura del futuro, o più semplicemente un chiaro segno di stanchezza, ch’è giocoforza pigli ogni generazione quando passa una certa età e viene inesorabilmente superata dalla successiva. Che poi, al di là dei corsi e ricorsi storici, ciascuna generazione abbia delle peculiarità irriducibili è ovvio. Ma questo va semmai a scapito nostro e a vantaggio delle nuove generazioni, che sembrano essere molto più disponibili e aperte verso il passato di quanto non lo fossimo noi. Da insegnante di scuola media ho un punto d’osservazione privilegiato sull’evoluzione e il mutamento dei gusti musicali, in questo senso. E devo dire che ho spesso notato un forte interesse dei giovani per – ad esempio – la Disco Music degli anni Settanta: Chic, Bee Gees, Earth Wind and Fire, Donna Summer, K. C. & the Sunshine Band, per fare solo alcuni nomi, sono molto apprezzati dagli adolescenti. Ho visto dei quattordicenni ballare entusiasti al ritmo di Stayin’ alive o di That’s the way (I like it), che sono brani di quarant’anni fa. Per fare un paragone, è come se noi – io sono del 1967 – avessimo ballato con entusiasmo, nelle discoteche tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, che so, Maramao perché sei morto o Alle terme di Caracalla. Vi immaginate? Il dj sarebbe stato picchiato a sangue, se avesse messo dischi del genere tra un pezzo di Sylvester e uno dei Village People. D’altra parte, non c’è certo bisogno di forzare l’intelletto per capire come oggi ci troviamo – e da decenni ormai – in una fase manierista e di revival totale e trasversale: basti pensare a un disco come Random access memories (2013) dei Daft Punk, che non è altro, da un punto di vista estetico, che una rivisitazione del Funk e della Disco (persino esplicita, negli omaggi dichiarati a Giorgio Moroder e a Nile Rodgers) filtrate dalla nuova sensibilità elettronica. Lo stesso discorso vale per il Rock in generale: gli adolescenti di oggi non hanno la benché minima percezione che Jailhouse Rock sia un brano di sessant’anni fa (per tornare al paragone precedente, è come se la nostra insegnante di musica delle medie ci avesse fatto ascoltare, nel 1978, Come Pioveva, che è del 1918); per loro Grease potrebbe essere stato fatto ieri (e qui forse il paragone è ancora più interessante: quanti di noi, allora, percepivano che il film, del 1978, parlava della gioventù degli anni Cinquanta, cioè di vent’anni prima?).
Se sembra dunque che oggi vi sia molta meno alternativa rispetto al passato, ciò è dovuto anche al fatto che il passato è molto più presente di quanto non lo sia forse mai stato. Se si guarda all’offerta attuale sembra effettivamente non vi siano molte alternative al mainstream – di qualità e livello comunque abbastanza differenziato – di un Ed Sheeran, un Justin Bieber o una Ariana Grande, al K-pop o al J-Pop e al binomio rap/trap, che assorbono quasi tutta la domanda, laddove nelle hit parade degli anni Settanta si trovavano cose ben più differenziate tra loro (rock, cantautorato, prog, punk, disco, metal, new wave, elettronica, colonne sonore, etc.) e lungo assi immaginari che potevano condurre dallo Zecchino d’Oro ai Throbbing Gristle o da Al Bano a Frank Zappa.
Tornando al ‘signorino’, trovo veramente incomprensibile che molti miei coetanei lo tacciano sic et simpliciter di banalità e di cialtroneria, due aspetti così fondamentali e importanti di quella cultura e di quell’immaginario pop in cui siamo immersi da più di cinquant’anni. Inoltre lo stile del nostro, come ho già sottolineato, attinge volentieri a modelli, quelli del nonsensee della poesia sonora, condivisi da una parte consistente delle avanguardie del Novecento. E che dire del trash, fenomeno estetico e culturale distinto dal kitsch, su cui si è scritto molto negli ultimi due decenni?[6] Che si stia diventando tremendamente e irrimediabilmente seri, tra tutti? Cos’è quest’ansia di storicizzazione, e quindi di selezione? Ci dimentichiamo troppo spesso che quando ci rappresentiamo il passato, in tutto il suo fascino sublime, lo filtriamo attraverso il genio e il capolavoro e lo epuriamo di ogni bassezza e inconsistenza, laddove un Rimbaud, ad esempio, nell’Alchimia del verbo ci ricorda quanto amasse “i dipinti idioti, soprapporte, addobbi, tele di saltimbanchi, insegne, miniature popolari; la letteratura fuori moda, latino di chiesa, libri erotici senza ortografia, romanzi delle bisnonne, racconti di fate, libretti per bambini, vecchie opere, ritornelli insulsi, ritmi ingenui”.
Per tornare meno seri, c’è un’espressione buffa del vernacolo livornese, essere un ‘signorino di nulla’, che si usa per designare chiunque, vecchio o giovane che sia, avanzi un po’ troppe pretese rispetto ai meriti effettivi che ha. Il che però, come spesso accade nel vasto e variegato repertorio di insulti a disposizione dei livornesi, non impedisce al designatore di serbare una qualche forma di empatia e di tenerezza per il designato, specie se più giovane.
[1] Sottogenere dell’Hip Hop affermatosi recentemente (in Italia è arrivato nel 2011) e caratterizzato da atmosfere e sonorità cupe e minacciose.
[2] S. Boezio, De instituzione musica, Roma, Istituto Italiano per la Storia della Musica, 1990, p. 289.
[3] Il giudizio di Bortolotto (“[…] un compositore insignificante […]. È bene ricondurre Satie alla sfera della socialità, della vita culturale francese, ma certamente escluderlo come capitolo, sia pure infimo, della storia della musica”) si può leggere in: J. Cage, Dopo di me il silenzio, Milano, Emme Edizioni, 1978, p. 125-126; quello di Berio (“[…] l’insensatezza musicale tutt’altro che disperata di un Morton Feldman e di uno Steve Reich (il primo scrive tutto pianissimo e il secondo produce dei gags vagamente incantatori sincronizzando e ripetendo con cocciutaggine squallidi patterns sonori che a poco a poco si ‘sfasano’)”) in: L. Berio, Intervista sulla musica, Bari, Laterza, 2007, p. 78.
[4] La testimonianza è in Aa. Vv., Donatoni, Torino, Edt, 1990, p. 47.
[5] Il brano linkato nel post a cui mi riferisco è Mmh ha ha ha, che si può ascoltare su YouTube all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=K9bf4PT-aEk. Oltre a questo brano, Young Signorino ne ha all’attivo, al momento, altri tre o quattro (Dolce droga, La danza dell’ambulanza, Padre Satana) che in breve tempo hanno avuto milioni di visualizzazioni.
[6] Cito qui un ‘classico’ di Tommaso Labranca, arguto scrittore prematuramente scomparso: Andy Warhol era un coatto. Vivere e capire il trash, Roma, Castelvecchi, 1994. Cfr. anche il coevo G. Salza, Spazzatura. La prima guida mondiale al trash, Roma-Napoli, Theoria, 1994.

