Beccatevi anche vesto, vai, oggi sono in vena…
Il massimo capolavoro del Novecento (un mistero italiano)
27 luglio 2009
Canzoncine
27 luglio 2009
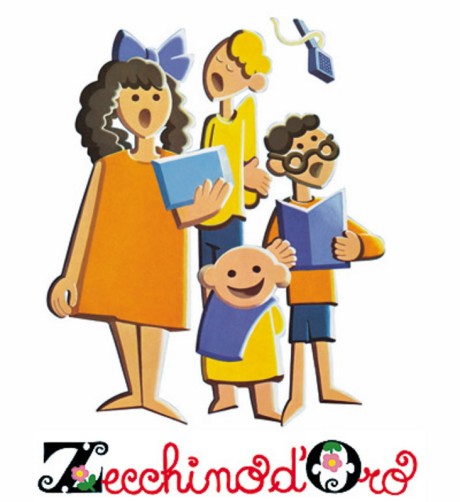
Che cosa sono le canzoncine? A pensarci bene, sono una cosa un po’ strana… sì, perché se si escludono le filastrocche e le canzoni di tradizione popolare che da secoli si imparano all’asilo (da Girotondo a Fra’ Martino, da Madamadorè a La pecora è nel bosco a Il mio bel castello), si può tranquillamente dire che esse siano state un’invenzione dell’Antoniano. Infatti, se di musica per bambini se ne è sempre scritta nel corso della storia, da Bach a Debussy a Stravinsky, si è sempre trattato di musica strumentale: di esercizi didattici (dai più semplici minuetti di Bach a Les cinq doigts di Stravinsky) oppure di composizioni semplicemente ispirate al mondo dell’infanzia (dalle Kinderszenen di Schumann al Children’s corner di Debussy, da Pierino e il lupo di Prokofiev al Babar di Poulenc). Ma di canzoni espressamente composte per l’infanzia (a parte appunto i più semplici canti popolari), canzoni cioè che ‘parlino’ dell’infanzia e siano cantate dai bambini, non mi risulta ne siano mai state scritte – mi corregga ovviamente chi ne sapesse più di me – prima di quelle dello Zecchino d’Oro, le quali dunque costituiscono, a tutt’oggi in Italia, il grosso del repertorio di questo ‘strano’ genere. Sì, ‘strano’ perché, mentre la letteratura strumentale per l’infanzia riposa sull’autoevidenza della sua natura didattica e propedeutica, non dobbiamo dimenticare che le canzoncine dello Zecchino d’Oro sono state scritte da adulti che si sono dovuti necessariamente fare un’immagine dell’infanzia, costringendo i veri protagonisti di essa – i bambini, appunto – a interpretare per così dire il ruolo di sé stessi. Voglio dire che non sono canzoni scritte dai bambini stessi, come sarebbe accaduto se invece di canzoni fossero stati disegni o poesie, e mancano quindi di quella freschezza che è propria dei disegni, delle poesie o dei movimenti spontanei di danza fatti dai bambini… Ed è per questo motivo che quelle canzoncine risultano spesso mielose, retoriche, talvolta addirittura vagamente perverse; insomma, sembrano cose scritte più per far commuovere le mamme e le zie che per far emergere i tratti più autentici ed essenziali dell’infanzia… Detto questo, non vorrei ovviamente far torto ad alcune delle meglio riuscite tra esse, a quelle poche eccezioni che si sono distinte nell’agone del fanciullino: da Il valzer del moscerino a Quarantaquattro gatti a E… ciunfete nel pozzo (la mia preferita, scritta da Gorni Kramer).
Ora, su questo mare di retorica svetta quel capolavoro assoluto, quell’unicum in tutti i sensi irripetibile che è stato l’album Ci vuole un fiore del 1974, frutto della collaborazione di tre grandi autori: Sergio Endrigo, Gianni Rodari e Luis Bacalov. Ecco, qui siamo lontani anni luce dalla retorica parrocchial-mocciosa dell’Antoniano; qui ci troviamo di fronte a canzoni, peraltro bellissime, scritte non solo per far divertire ma anche per fare riflettere i bambini, sull’onda di quel rinnovamento pedagogico della scuola italiana che proprio in quegli anni si andava profilando e che raccoglieva l’eredità, bella fra tutte, dell’opera inestimabile di Rodari. Napoleone, Un signore di Scandicci, Le parole, Ho visto un prato, Non piangere: piccoli gioielli sempre freschi e attuali che vanno a congiungersi alle altre canzoni dedicate da Endrigo ai bambini in quel periodo (La casa, La marcia dei fiori, etc.). Una stella splendente, insomma, che ancora oggi brilla di luce propria in un settore che, specialmente negli ultimi anni, è andato sempre più inaridendosi e scompaginandosi in una irreversibile deriva.
PS Dimenticavo: anche le sigle dei cartoni animati rientrano bene o male in questa categoria… ma di questo parleremo in un altro post.
Il popolo unito non sarà mai vinto (a parte in Italia, oggi)
26 luglio 2009
- El pueblo unido jamás será vencido,
- ¡el pueblo unido jamás será vencido!
- De pie, cantar, que vamos a triunfar.
- Avanzan ya banderas de unidad,
- y tú vendrás marchando junto a mí
- y así verás tu canto y tu bandera florecer.
- La luz de un rojo amanecer
- anuncia ya la vida que vendrá.
- De pie, marchar,
- el pueblo va a triunfar.
- Será mejor la vida que vendrá
- a conquistar nuestra felicidad,
- y en un clamor mil voces de combate
- se alzarán, dirán,
- canción de libertad,
- con decisión la patria vencerá.
- Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
- con voz de gigante gritando: ¡Adelante!
- El pueblo unido jamás será vencido,
- ¡el pueblo unido jamás será vencido!
- La patria está forjando la unidad.
- De norte a sur se movilizará,
- desde el Salar ardiente y mineral
- al Bosque Austral,
- unidos en la lucha y el trabajo irán
- la patria cubrirán.
- Su paso ya anuncia el porvenir.
- De pie, cantar que el pueblo va a triunfar
- millones ya imponen la verdad.
- De acero son ardiente batallón.
- Sus manos van llevando la justicia
- y la razón, mujer,
- con fuego y con valor,
- ya estás aquí junto al trabajador.
- Y ahora el pueblo que se alza en la lucha
- con voz de gigante gritando: ¡Adelante!
- El pueblo unido jamás será vencido,
- ¡El pueblo unido jamás será vencido!
Albert e l’uomo nero
25 luglio 2009

Saprete (o immaginerete) che sono un grande appassionato di sceneggiati televisivi degli anni Settanta, in particolare degli ‘originali’, che si distinguono dai veri e propri sceneggiati perché non hanno in genere alcun romanzo a monte, ma sono, come l’espressione stessa ci dice, pensati in origine per la televisione e ad essa destinati. Quindi amavo e amo di più i vari Gamma, Ritratto di donna velata e Il segno del comando che non Sandokan, Madame Bovary o Il conte di Montecristo. La ragione è che negli originali, per forza di cose, quello spirito così ineffabile, quell’atmosfera così misteriosa e perversa caratteristica degli anni Settanta emergeva più perentoriamente con tutto il suo immaginario simbolico che non negli adattamenti di romanzi tratti dalla letteratura universale, nei quali invece rimaneva più sullo sfondo, in sordina, quando non era del tutto assente.
Tra i molti originali televisivi che sono rimasti scolpiti nella mia memoria, Albert e l’uomo nero è, insieme a La mia vita con Daniela, il più inquietante e perverso: qui quel senso di gratuità, quella cospicua dose di irrazionalità cui più volte ho fatto cenno nei miei post, emerge chiaramente in tutta la sua forza. La trama, che per la fiction di oggi sarebbe semplicemente impensabile, sembrava fatta apposta per spaventare i più piccoli: un bambino di nove anni, Albert, si ritrova solo in casa di notte per vari motivi (che sono ovviamente dei non-motivi – una volta il padre e la zia rimangono a dormire da un amico perché si guasta la macchina, un’altra volta la governante esce di casa per incontrarsi con un amante lasciando il bambino da solo in questa grande villa del ravennate) e riceve le visite di un uomo “completamente nero dalla testa ai piedi”, come dice Albert al commissario Gandini nella prima delle tre puntate trasmesse nel marzo 1976, senza che ovviamente se ne comprenda il motivo prima della fine.
Un’altra delle ragioni per cui amavo moltissimo questi originali era la musica che li accompagnava, generalmente languida e inquietante: come dimenticare A blue shadow o il Tema di Silvia di Romolo Grano, scritte per Ho incontrato un’ombra? o la musica di Migliardi per A come Andromeda? O ancora, quella di Cipriani per Dov’è Anna e quella di Simonetti, languidissima tra tutte, per Gamma?… e il terrore che incuteva la Ballata di Carini, sempre di Grano, che sottolineava magistralmente la scena au ralenti dell’uccisione della baronessa con l’impronta della mano insanguinata sul muro, ne L’amaro caso della baronessa di Carini? Tracce indelebili che hanno scavato l’inconscio di un’intera generazione… La musica di Albert e l’uomo nero fu scritta invece dal compositore romano Franco Micalizzi, autore di molte colonne sonore per il cinema, oltre che per la televisione, di quegli anni.
PS Scusate, sopra ho scritto una cazzata: Sandokan ovviamente mi ha fatto gioire e tremare come pochi altri, ma è stata un’eccezione tra gli sceneggiati tratti da romanzi.
Commenti (potere ai giovani)
22 luglio 2009

Questo è il commento di una diciassettenne a un mio post* nel quale esprimo tutta la mia insofferenza e antipatia per la conduttrice televisiva Maria De Filippi:
MARIA DE FILIPPI è UNA GRANDE …. PER NN PARLARE DEL PROGRAMMA CHE CONDUCE LA VERITà è CHE SE NN CONOSCETE MARIA DE FILIPPI SIETE IGNORANTI MA NN XKè NN GUARDATE LA TELEVISIONE MA PERCHè NN VI INFORMATE ANCHE PERCHè, SOLO LEGGENDO UN QUOTIDIANO SI PUù INCROCIARE IL NOME :MARIA DE FILIPPI E VOI SIETEDEI GRANDIXIMI ROSICONI , XKè SE MARIA DE FILIPPI DESSE ANCHE A VOI UNA SCHANS COME LA DA A I RAGAZZI CON UN TALENTO VORREI VEDERE SE RIDICESTE MA CHI è MARIA DE FILIPPI!!!!!!!!!!!!
Che dire? Ora e sempre evviva i giovani…
(boia, m’ha steso…)
* https://marcolenzi.wordpress.com/2009/03/18/nemico-di-maria-de-filippi/
Che cosa significa avere competenze musicali?
21 luglio 2009

Quello della competenza musicale è un argomento che mi interessa moltissimo da lungo tempo e che, forse perché tocca questioni che vanno anche al di là dello specifico musicale, stimola sempre in me nuovi motivi di riflessione. Esso può essere così sintetizzato: che cosa può significare avere delle competenze musicali? E che rapporto c’è tra queste competenze e la musica stessa?
Cominciamo subito con l’esempio di due artisti diversissimi tra loro ma entrambi legati alla musica pur non essendo musicisti: Stanley Kubrick e Carmelo Bene. Ecco, io penso che essi siano stati artisti musicalmente dotatissimi pur non avendo mai acquisito nella loro vita specifiche ‘competenze’ musicali. L’incredibile, straordinaria capacità di Kubrick di individuare la musica giusta per accompagnare le immagini dei suoi film e l’altrettanto incredibile, straordinaria capacità di Bene di modulare la propria voce secondo criteri ‘musicali’ (prosodici, timbrici, dinamici, agogici in senso lato) sono doti che nessun ‘vero’ musicista ha mai posseduto al loro livello. Intendo dire con ciò che nessun musicista, per quanto bravo e preparato, avrebbe potuto scegliere musiche migliori per Kubrick o consigliare migliori alternative a Bene in fatto di modulazione vocale.
Ora, ci potremmo chiedere come hanno fatto Kubrick e Bene ad acquisire queste competenze, competenze non facilmente definibili ma indubbiamente musicali. Non so come le abbiano acquisite, ma sicuramente hanno saputo svilupparle, accrescerle, affinarle, in una parola migliorarle nel tempo. Ciò significa che le loro sono comunque competenze, e che non tutti le possiedono al loro livello. Vi sono cioè differenti livelli di competenza musicale anche in questo caso, esattamente come vi sono nel saper suonare uno strumento musicale: l’unica distinzione tra questi due tipi diversi di competenza è che le differenze nel secondo tipo le vedono quasi tutti, mentre quelle nel primo sfuggono a molti. Ma ciò non significa che quella del primo tipo non sia una competenza musicale.
C’è invece un pregiudizio ancora purtroppo assai diffuso, specialmente presso i musicisti, per il quale nella musica, più che in qualsiasi altra forma d’arte, non si può assolutamente prescindere dalla cognizione completa della sua teoria e della sua tecnica per raggiungere un livello qualitativo dignitoso, o meglio per il quale il livello di competenza raggiunto dai musicisti e dagli ascoltatori nelle cognizioni tecniche e teoriche si riflette direttamente sul valore delle opere dai primi prodotte e dai secondi apprezzate. Ciò significa, in altre parole, che mentre si riconosce che un regista o un pittore possano essere grandi registi o grandi pittori anche se, per così dire, non hanno frequentato la Scuola di Cinematografia o l’Accademia di Belle Arti, cioè anche se non conoscono la teoria del cinema e della pittura, generalmente non si accorda al musicista lo stesso diritto, ragion per cui al jazzista o al musicista pop non sarebbe consentito scrivere ‘capolavori immortali’ ma soltanto opere che sono tutt’al più fedele espressione di un contesto storico contingente. C’è insomma presso tanti musicisti (guarda caso quasi tutti di formazione classica) una sovrastima dell’elemento teorico che è ancora dura a morire.
Eppure Bach non si è ‘diplomato in composizione’, non ha imparato a comporre studiando i trattati di contrappunto ma ascoltando e studiando nel vivo della loro esperienza esecutiva le opere di Vivaldi e di Buxtehude, che all’epoca costituivano, insieme a quelle di pochi altri compositori, l’unico referente possibile per formare il proprio gusto e per acquisire competenze musicali. Oggi, soprattutto grazie alla tecnologia (si pensi per esempio alla figura del Dee Jay e all’incredibile evoluzione che essa ha avuto negli ultimi anni), ma anche all’enorme quantità di stimoli estetici che provengono dalle fonti più diverse e disparate, tale spettro di referenze si è ampliato a dismisura e l’approccio teorico costituisce soltanto uno (e non necessariamente il migliore) tra i tanti approcci possibili alla musica. E non solo per ciò che riguarda la produzione, ma anche nell’ambito della fruizione della musica si sono sviluppate competenze molto differenziate, che prescindono totalmente dalle cognizioni tecniche. Il mio amico Nicola Perullo, per esempio, che non ha mai studiato musica, ha un gusto molto più raffinato di tanti musicisti professionisti che conosco (non pochi dei quali non saprebbero riconoscere la qualità musicale dei Velvet Underground o dei Joy Division ma apprezzano gente come Ron o Amedeo Minghi). È un gusto, il suo come quello di tanti altri attenti e raffinati ascoltatori, che si è formato fuori dai libri e dalle scuole di musica, che ha beneficiato di contributi culturali esterni ad essa che però non gli hanno impedito di apprezzare sfumature qualitative anche interne alla musica, sfumature che se egli non sarebbe in grado di definire in termini tecnici pure sa descriverle con espressioni verbali che non solo non travisano o non impoveriscono ma che anzi arricchiscono il valore della musica in sé.
Insomma, credo che i percorsi da seguire per arrivare al cuore della musica siano tanti e diversi, così come le tipologie e i livelli di competenza che possono essere acquisiti lungo questi affascinanti cammini; sta a noi (ai musicisti in primis) riconoscerli e apprezzarli come contributi essenziali a un nuovo e più articolato complesso di saperi musicali che metta a disposizione di tutti, non solo delle scimmiette che suonano Chopin a sette anni, una delle cose più belle e straordinarie che l’umanità abbia mai prodotto.
Il Mozart del 2000 (non è Allevi)
19 luglio 2009

Ecco, se c’è qualcuno che merita di essere definito ‘il Mozart del 2000’ è Richard D. James, meglio noto come Aphex Twin. Sono appena uscito da uno straordinario dj set di un’ora e mezzo che il musicista inglese ha tenuto a Livorno, per l’Italia Wave Love Festival, performance che non solo ha tenuto testa, ma addirittura ha quasi fatto passare in secondo piano quella dei musicisti che lo hanno preceduto (nientemeno che i Kraftwerk!…). Un evento davvero incredibile: due delle tre o quattro massime espressioni dell’elettronica mondiale (gli altri sarebbero, a mio avviso, gli Autechre e i Daft Punk) che si ritrovano a dividere il palco in una piccola città come Livorno nella stessa serata… erano esattamente vent’anni, cioè dal concerto dei Pink Floyd, che la città del Vernacoliere non ospitava musicisti di primissimo piano (anche se i Pink Floyd, ovviamente, allora erano già l’ombra di sé stessi da un bel po’ di tempo…).
Genio multiforme e visionario, James ha ‘intrattenuto’ il suo pubblico (circa cinquemila persone) con uno show immaginifico e di fortissimo impatto emotivo che ha evidenziato le sue innegabili e straordinarie doti di musicista tout court: una fantasia inesauribile, una estrema raffinatezza nella scelta dei timbri, ricca e varia quanto altre mai, e una sbalorditiva abilità nella loro sapientissima combinazione in strutture ritmiche complesse e continuamente cangianti. Pur privilegiando la componente più estrema e caustica della sua poetica (l’ossessione per l’incessante e perversa deformazione del proprio volto e la predilezione per temi violenti e profondamente angoscianti), Aphex Twin ha scritto anche pagine di grande dolcezza (Nannou su tutte, un tenerissimo carillon che sgrana sonorità eteree disciolte in disegni ritmici irregolari e di grande fascino), che testimoniano del suo approccio fondamentalmente eclettico e onnivoro al fenomeno sonoro. Perfetta, ovviamente, anche la simbiosi audiovisiva, che ha toccato vertici di intensa poesia nella collaborazione con Chris Cunningham per i video di Come to daddy e di Windowlicker, e che ieri sera, verso la fine della performance, si è incarnata in un tour de force senza respiro proprio sul tema della metamorfosi facciale.
Che dire? Mah, di solito, ogni volta che ho avuto occasione di esprimermi sul presente e sul futuro della musica, ho tenuto un atteggiamento di riserbo piuttosto pessimistico, talora addirittura apocalittico; ma certo, la presenza e la vitalità di artisti come Aphex Twin fa ben sperare… che sia un nuovo faro capace di illuminare nuovi orizzonti? Se è così, allora ben tornato, carissimo Wolfgang!
Scenderemo nel gorgo muti
13 luglio 2009
Avevo completamente rimosso l’esistenza di un film in cui Al Bano interpreta Franz Schubert. Devo al fraterno amico e mio carnefice prediletto Michele Faliani il merito di aver recuperato questa perla dalla cloaca dell’inconscio.
PS da notare la finissima e simmetrica distinzione della musica in “canto, armonia e melodia” (cioè come a dire in ‘canto, armonia e canto’) che Bano mette in bocca a Schubert. Dopo Brugiolo, un altro fendente mortale dall’universo lisergico di quegli anni (fine Sessanta – primi Settanta)…
Educazione sentimentale
12 luglio 2009
